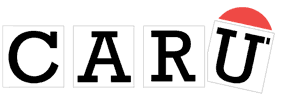l`offerta di proposte educativo-formative indirizzate alla terza eta` si sta facendo sempre piu` ricca e variegata. gli anziani di oggi sono soggetti attivi che, una volta raggiunta l`eta` della pensione, intendono impiegare in modo proficuo il tempo libero. la presenza di questi "nuovi discenti" richiede alla pedagogia di riflettere sul modo di favorire e valorizzare le occasioni di apprendimento e formazione per garantire agli anziani un ruolo attivo nella societa`. ma quale modello di insegnamento e apprendimento e` piu` adatto, utile ed efficace per i discenti della terza eta`? come si possono promuovere, attraverso l`educazione, contatti tra generazioni diverse? queste sono alcune delle questioni su cui il testo intende riflettere.


i saggi che compongono questo libro obbediscono a una strategia comune: indagare un testo letterario muovendo dalla convinzione che siano i piccoli e piccolissimi indizi, le labili tracce di cui e` cosparsa la sua superficie a mettere sulla strada della comprensione. le imperfezioni e le incongruenze che fanno funzionare la macchina testuale si nascondono li`, sotto gli occhi di tutti, e il talento del critico sta nel ricostruirle con la meticolosita` paziente del decifratore. lavagetto articola questi assunti nei "frammenti di una teoria", per poi trasformarli in sapientissimi esercizi di lettura, da balzac a collodi a stendhal, dai libretti verdiani a freud a proust.


publio virgilio marone (70-19 a.c.) e` il poeta latino che piu` di ogni altro ha impresso profonda traccia di se` nella letteratura occidentale dei secoli a venire, da dante a hermann broch. le sue creazioni poetiche - le "bucoliche", le "georgiche" e ancor piu` il suo capolavoro assoluto: l`"eneide" - hanno rappresentato nel tempo un modello di stile per i poeti e una lettura canonica per la classe colta europea. mancavano pero` sinora lavori utili a presentarne la figura e l`opera al di fuori della cerchia degli specialisti. a questo provvede oggi il volume di holzberg, che attraverso un`attenta ricostruzione della vicenda biografica del poeta di mantova, e rileggendo una ricchissima serie di esempi testuali, introduce il lettore al fascino dell`arte di virgilio e al ruolo preminente che questi ebbe nella vita letteraria, politica e sociale dell`eta` augustea.

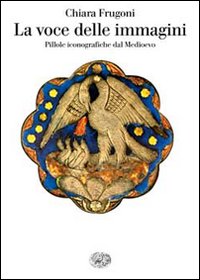
pillole iconografiche si propone di mettere a suo agio il visitatore di una mostra, di un museo. la prima parte del volume e` dedicata ai gesti in codice: come attraverso le dita, la posizione delle braccia e delle gambe si possano comunicare situazioni ed emozioni; alle convenzioni iconografiche riguardanti gli edifici e le loro relazioni con i personaggi: come veniva resa la tridimensionalita`, la prospettiva, il dentro e il fuori, il dietro e il davanti. un capitolo e` dedicato alla rappresentazione del diverso, a tutti i modi con cui si declinava l`antisemitismo e l`avversione per le persone di colore. due capitoli sono consacrati a maria e a cristo (alla vita di maria, al suo rapporto con il figlio bambino; a cristo nella sua vita terrena con una particolare attenzione al ciclo della passione, fino al ritorno nei cicli dove sale anche la madre, regina della corte celeste); in essi e` spiegato anche il significato di frutta, fiori e fauna (dal leone al pettirosso), associati alle loro rappresentazioni. l`ultimo capitolo e` dedicato ad alcuni tratti simbolici, come ad esempio alla differenza fra nimbo a raggi e nimbo tondo intorno al capo, al significato del nimbo esagonale, al signum viventis. completa il volume un indice analitico particolarmente minuzioso e un dizionarietto delle parole tecniche.


che cosa e` stato il fascismo? reazione o rivoluzione? in realta` un fenomeno articolato e complesso. contro il regime autoritario e conservatore edificato negli anni venti dal nazionalista alfredo rocco, resiste e si sviluppa il fascismo delle origini (facente capo a giuseppe bottai ma per alcuni versi allo stesso mussolini), rivoluzionario e totalitario, deciso a seppellire la "civilta` borghese" e a fondare la "nuova civilta` fascista", una "terza via" alternativa tanto al liberal-capitalismo quanto al comunismo. paolo buchignani ricostruisce in modo organico la travagliata vicenda del fascismo rivoluzionario fino alla sconfitta finale. un esito che nulla toglie all`importanza e alla pericolosita` di quel sovversivismo in camicia nera, tanto intransigente e totalitario quanto vitale, progettuale, proiettato nel futuro e, di conseguenza, capace di garantire al duce (cui attribuisce la sua stessa volonta` rivoluzionaria) il consenso delle classi lavoratrici e popolari, dei giovani, degli intellettuali. inevitabile il fallimento di un disegno politico che, almeno in parte, andava progressivamente realizzandosi nella seconda meta` degli anni trenta? la trasformazione del fascismo in regime totalitario (e rivoluzionario) e` stata un esperimento interrotto? e si puo` dire che il regime mussoliniano, figlio della prima guerra mondiale, sia stato ucciso dalla seconda? questo studio ffronta questi e altri nodi fondamentali, riaprendo questioni tuttora irrisolte del nostro novecento.


il bilancio di un secolo della nostra letteratura nelle pagine di uno dei maggiori critici del novecento. dal futurismo all`ermetismo, da pascoli a montale, contini imbastisce un canone della cultura italiana piu` recente, annoverando al suo interno non solo poeti e narratori, ma anche scrittori di prosa scientifica, critica e politica, nonche` i movimenti collettivi italiani e stranieri che hanno contribuito a tracciarne le rotte poetiche. introduzione di cesare segre.


dell`irripetibile e composito universo artistico di miro` (1893-1983), la testimonianza scritta e` una straordinaria via di accesso. miro` conosceva e amava la letteratura, spesso anche la illustrava, e sapeva esprimere nei suoi scritti l`essenza segreta del suo caleidoscopico mondo. essi sono uno strumento insostituibile per conoscere l`opera e la vita di uno dei piu` noti artisti del novecento, che ancora affascina con le sue opere giocose, funambolesche, lontane da ogni schema, cosi` libere e selvagge, ma anche cosi` profondamente vicine ai drammatici eventi (soprattutto la guerra civile che insanguino` la sua patria, la spagna) di cui fu partecipe testimone.

oggi i nonni non hanno il bastone, ne` storie avventurose da raccontare o mestieri da trasmettere, ma giocano a tennis, viaggiano, studiano, guidano l`automobile, vivono da soli. serve quindi un cambiamento culturale che consenta di scoprire cio` che la vecchiaia puo` significare oggi: una fase di liberta`, di liberazione dal lavoro, dal peso delle responsabilita`, dagli impegni, tutta da inventare e progettare, lasciandosi alle spalle la sclerosi dell`eta` adulta. in quest`ottica vanno ridiscusse molte cose: l`approccio medico, il sistema assistenziale, la politica del lavoro, l`organizzazione sociale. il libro fa il punto su tutti questi cambiamenti, restituendoci un`immagine dell`invecchiare che non coincide con quella statica di un tempo.

come rimediare agli errori del passato? come imparare a perdonarsi? come riuscire a prendere decisioni e a fare scelte con serenita`? un libro che non offre illusorie bacchette magiche ma che, attraverso la psicoterapia cognitiva, vi aiuta a riscoprirvi. come se steste conversando con il vostro psicoterapeuta. concretamente, senza fronzoli, per ricevere idee e suggerimenti oltre che per riuscire a prendere le decisioni migliori in ciascuna fase della vita. leggendolo, potrete cambiare in parte il vostro modo di pensare o allargare i confini della vostra mente. sarete invitati a prendere in considerazione elementi che forse avevate trascurato prima perche` non sapevate che fossero importanti o perche` magari non sapevate come fare i conti con il vostro passato e con le vostre esperienze precedenti. nessuno vuole essere infelice. se le persone sono infelici, insoddisfatte o terrorizzate non lo fanno apposta: ci si trovano. tuttavia, ci sono sempre scelte possibili e fruttuose, a qualsiasi eta`. due lettori immaginari, paolo (dirigente d`azienda) e arianna (psicologa psicoterapeuta), vi accompagneranno in questo percorso, commentando e discutendo con l`autore alcuni argomenti, interrompendo la stesura del libro con domande, osservazioni, battute di spirito, rilievi e critiche. un libro di psicologia che si legge come un romanzo con la verve di una commedia.

il male che si accanisce contro giobbe non puo` piu` essere concepito come una punizione, poiche` egli non ha commesso alcun delitto; non puo` piu` essere una vendetta, poiche` egli non ha colpito nessuno. nel trovarsi esposto alla violenza insensata della sofferenza giobbe si trova immerso in una esperienza intraducibile. resta solo il grido rivolto a dio come il modo piu` radicale della domanda. la stessa che egli porta nell`etimo del suo nome: giobbe significa nella lingua ebraica domanda che sovrasta ogni possibile risposta. . il grido di giobbe accade quando le parole sono costrette al silenzio, spezzate dal trauma del male. esso non e` indice di rassegnazione ma di lotta e di resistenza. dopo la notte del getsemani e il gesto di caino, con il grido di giobbe continua l`intenso e sorprendente viaggio di massimo recalcati lettore della bibbia, impegnato a rintracciare l`eredita` piu` profonda del pensiero psicoanalitico che si concludera`, a breve, con un`ampia e attesa opera.

sono le 22,00 del 29 luglio 1900. siamo a monza e il re umberto i sta salendo in carrozza dopo aver premiato i ginnasti della societa` "forti e liberi". ad aspettarlo c`e` il revolver di gaetano bresci, l`anarchico venuto dall`america. pochi istanti dopo l`italia intera entrera` in una nuova epoca.

"l`ipotesi che esista una sola psicologia o un solo principio psicologico fondamentale costituisce un`intollerabile tirannia", cosi` jung a proposito di questa che forse e` la sua opera piu` famosa. con tipi psicologici si abbandona la pretesa, ancora radicata in freud, di concepire la psicologia come scienza esatta, e si riconosce la presenza ineliminabile di un fattore soggettivo. qui jung integra la scoperta dell`inconscio con la definizione e la descrizione degli otto tipi psicologici principali. tipi psicologici e` anche un trattato di psicologia, ricco di casi clinici, e una storia del pensiero umano, in cui jung ricostruisce i conflitti sorti dalla presenza dei due caratteri fondamentali, "apollineo" e "dionisiaco", che hanno dominato lo spirito nella filosofia e nelle arti da platone a goethe, da aristotele a nietzsche. qui jung dispiega tutto il suo fascino di evocatore di miti, personaggi, civilta` scomparse.

a duecento anni dalla sua nascita, baudelaire e` il caso molto raro di uno scrittore che ha mantenuto intatta la sua forza di penetrazione intellettuale e la capacita` di scardinare ogni forma di pensiero sclerotico. dopo la folie baudelaire, che era un vasto libro non solo su baudelaire ma su tutta la parigi intorno a lui, roberto calasso ha voluto concentrarsi su cio` che costituisce la singolarita` irriducibile dello scrittore - innanzitutto il taglio della sua intelligenza e quel gusto che ha dato un`impronta definitiva a cio` che si e` poi chiamato il moderno.



se "il capitale" rimane un testo inaggirabile per ogni rivoluzionario che voglia dare solide basi alla propria passione, lo si deve a un metodo di analisi che, come scrisse lenin, "ha dato un criterio completamente oggettivo, discriminando i rapporti di produzione come struttura della societa` e dando la possibilita` di applicare a questi rapporti quel criterio scientifico generale della reiterabilita`, la cui applicazione alla sociologia era negata dai soggettivisti. [...] marx non si limito` alla sola "teoria economica" nel senso abituale della parola, [...] investigo` cio` nondimeno sempre e dappertutto le sovrastrutture corrispondenti a questi rapporti di produzione, rivesti` lo scheletro di carne e di sangue. se "il capitale" ebbe un successo cosi` gigantesco, e` perche` questo libro di un "economista tedesco" mostro` al lettore tutta la formazione sociale capitalistica come una cosa viva, con i suoi aspetti della vita quotidiana, con le manifestazioni sociali concrete dell`antagonismo delle classi inerenti ai rapporti di produzione". il volume e` introdotto dal primo capitolo di "lotte di classe e partito rivoluzionario" di arrigo cervetto, in cui sono riprese le tesi di lenin sull`opera di marx.

l`hacking non nasce con i computer. gia` agli inizi del novecento dei giovani appassionati modificavano i propri apparecchi radio per ottenere prestazioni non previste dal loro produttore. alcuni decenni dopo, negli anni `60, si diffondono i `phone phreaks`, degli `hacker dei telefoni` che prefigurano molte caratteristiche della odierna cultura digitale. con la diffusione dei pc i gruppi hacker diventano un fenomeno mediatico e di massa. alla meta` degli anni `80, quello che fino ad allora era stato considerato come un `ragazzo prodigio` si trasforma in una potenziale minaccia come autore di clamorose truffe o altre pratiche criminali. ma in quegli stessi anni le pratiche hacker cominciano ad assumere un valore politico: nascono il cosiddetto hacktivismo e le comunita` free software e open source, che in poco tempo rivoluzioneranno l`industria del software e la cultura digitale nel suo complesso. oggi il fenomeno hacker e` arrivato a occupare un ruolo di primo piano nella geopolitica contemporanea grazie alla nascita di gruppi su scala globale come anonymous e all`incorporazione dell`hacking nelle strutture militari e di intelligence.

quasi un decennio dopo "farla finita" con eddy bellegueule, il suo esordio divenuto un caso editoriale internazionale, edouard louis torna a parlare della sua storia e lo fa con un romanzo malinconico, lucido e affascinante. una storia di apprendimento, di lotta e di metamorfosi per sfuggire alla poverta`, alla violenza e all`esclusione. il racconto del percorso lungo e doloroso che l`ha portato da un`infanzia difficile, segnata dalla miseria economica, morale e culturale, ad affermarsi come una delle voci piu` forti e interessanti della letteratura francese. "metodo per diventare un altro" e` un viaggio che, da racconto autobiografico, si fa denuncia della societa` e del sistema di valori in cui viviamo, ma che vuol essere anche una speranza per chiunque voglia, sopra ogni cosa, essere se stesso.

all`inizio, internet era un luogo senza legge, popolato da geni della truffa che rendevano l`acquisto o la vendita di qualsiasi cosa online un affare rischioso. poi amazon, ebay, upwork e apple crearono piattaforme digitali sicure per la vendita di beni fisici, la ricerca di un lavoro e il download di app. in seguito, pero`, questi giganti della tecnologia hanno continuato a governare internet come autocrati. come e` potuto accadere? in che modo utenti e lavoratori sono diventati gli sfortunati sudditi degli imperi economici online? internet non doveva liberarci dal potere delle istituzioni? l`esperto di economia digitale vili lehdonvirta ci racconta il rapporto tra tecnologie digitali e societa` prendendo di volta in volta spunto dalla storia di un personaggio influente o di una piattaforma significativa tra quelli che hanno contribuito a plasmare l`odierna economia digitale, da nomi familiari come jeff bezos di amazon a eroi misconosciuti come kristy milland di turker nation. lehdonvirta esplora l`ascesa dell`economia delle piattaforme verso il dominio completo delle nostre vite e propone una via alternativa da seguire. perche` solo se comprendiamo le piattaforme digitali per quello che sono - istituzioni potenti come stati - possiamo avviare una vera fase di democratizzazione.

la storia di una delle piu` instabili regioni del mondo, dal dominio della dinastia moghul del xvi secolo fino alla rinascita talebana di oggi. le lotte per il potere e la natura mutevole dell`autorita` politica di un paese dai caratteri unici e tragicamente tornato d`attualita` internazionale. una lettura imprescindibile per capire come una terra conquistata e governata dagli stranieri per piu` di mille anni pote` diventare per inglesi, sovietici e americani la . questa storia dell`afghanistan intreccia geografia, politica, economia e cultura per descrivere le dinamiche interne e le relazioni col mondo esterno di una nazione estremamente complessa. dopo aver illustrato la sconcertante diversita` dei gruppi tribali ed etnici afghani - spiegando cosa li unisce nonostante le differenze regionali, culturali e politiche che li dividono - thomas barfield dimostra quanto per secoli sia stato relativamente facile governare tutti questi popoli quando il potere era concentrato in una piccola e`lite dinastica, e come questo fragile ordine politico sia poi crollato nel xix e xx secolo, quando i governanti dell`afghanistan mobilitarono le milizie rurali per espellere prima gli inglesi e poi i sovietici. l`insurrezione armata sbaraglio` gli occupanti, ma mino` l`autorita` del governo afghano e rese il paese sempre piu` ingovernabile. le fazioni armate interne innescarono una guerra civile, dando origine al governo clericale dei talebani e all`isolamento dell`afghanistan dal mondo. barfield esamina infine i motivi per cui l`invasione americana, sulla scia dell`11 settembre, riusci` a rovesciare rapidamente i talebani e perche` quella facile vittoria fece credere agli stati uniti che fosse altrettanto facile costruire un nuovo stato.

sulla base del materiale raccolto pirjevec ha ricostruito le sei diverse guerre susseguitesi nel territorio della ex-jugoslavia dal 1991 al `99 nei loro risvolti politico-militari e nelle loro implicazioni internazionali, concentrando l`attenzione tanto sulle dinamiche interne e sugli aspetti sociali, che le hanno condizionate, quanto sull`intervento delle grandi potenze e organizzazioni. ne e` nato un affresco complesso ma di agile lettura grazie all`articolazione del racconto, diviso in sette capitoli fondamentali relativi ad altrettanti nuclei tematici.

chi racconta di papa` goriot? a chi appartengono le voci che raccontano di edward waverley, di emma bovary o del lettore di se una notte d`inverno un viaggiatore? i narratologi strutturalisti hanno affermato che in ogni narrazione letteraria dobbiamo distinguere la persona storica dell`autore dall`istanza testuale del narratore e questa distinzione e` rimasta al centro della narratologia. ancora oggi, mentre crescono le narratologie postclassiche, essa resta valida e necessaria per la maggioranza degli studiosi. questo saggio sostiene invece che distinguere a priori autore e narratore non consenta di rendere conto di interi periodi della storia del romanzo e che la questione teorica - chi racconta in una narrazione letteraria? - debba essere posta su un terreno ermeneutico e storicista. idee diverse di romanzo erano presenti a scott e balzac, a flaubert e ai modernisti o a calvino e ai postmodernisti. a queste diverse idee e alle opere che le espressero deve corrispondere una visione complessa, che integri le categorie teoriche con una riflessione ermeneutica e storicista sulle opere e sul genere del romanzo.

nella ricchissima produzione culturale palestinese la storiografia svolge un ruolo fondamentale, come ben mostra questo libro, che ha il merito di ripercorrere con chiarezza le fasi salienti della questione palestinese dal periodo ottomano sino a oggi, riproponendo episodi e idee di una vicenda in parte nota ma che e degna di essere conosciuta da chi la ignora e mantenuta viva nella memoria di chi l?ha dimenticata o continua a dimenticarla. occuparsi dei palestinesi non e infatti faccenda per pochi specialisti, ma nodo centrale della storia contemporanea e punto di confluenza delle sfide globali. i due autori ci offrono un?importante "narrazione dall?interno", nella quale sono accolte, attraverso il ricco apparato bibliografico, anche molte altre voci palestinesi e arabe, oltre che occidentali.

scritte tra il 1955 e il luglio del 1960 e pubblicate per la prima volta nel 1961, le poesie di "la religione del mio tempo" raccontano in versi un?intera societa in fermento. usando la frusta quando lo ritiene necessario, pasolini non retrocede di fronte a nulla e utilizza ogni possibile materiale argomentativo: da quello metafisico a quello polemico, dal giornalistico al profetico, proponendo schemi e ideologie che - come spieghera sul settimanale "vie nuove" - "non sono solo opinioni politiche, ma sono, insieme, poetiche; hanno cioe subito quella trasformazione radicale di qualita che e il processo stilistico". in questa raccolta pasolini riesce cosi a mettere poeticamente in azione tutta la sua incontenibile passione civile, un?insaziabile fame di vita e un irresistibile desiderio di capire e sentire. prefazione di franco marcoaldi.


vent?anni fa, l?ingresso di pechino nel wto, la svolta dell?euro in europa e le guerre del declino americano erano i "fatti politici" che avviavano una "nuova fase strategica" perche la cina, una potenza emersa dalle aree arretrate, spartite e sviluppate dall?imperialismo, arrivava a sfidare l?ordine postbellico e a chiedere una nuova spartizione del mondo. il passaggio chiedeva un?attenzione specifica per le varianti e le sfumature della politica estera cinese, per il pluralismo delle scuole di pensiero, per gli adeguamenti e le variazioni nel tempo dei loro orientamenti. in assenza di un lavoro sistematico serio tra le fonti occidentali, abbiamo recensito alcune delle filiere principali dalla vasta pubblicistica in cinese. per la prima volta un rivolgimento mondiale di enormi proporzioni scaturisce dalla "collisione imperialista" della potenza cinese. solo il marxismo poteva prevedere con larghissimo anticipo una tale dialettica della "collisione storica" e mantenere l?attenzione, per due secoli, sul "curioso spettacolo [...] della cina che esporta disordine nel mondo occidentale". sara una collisione mai vista prima nell?ordine delle classi dominanti.