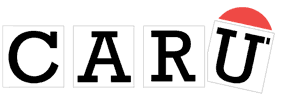"se un denominatore comune hanno queste novelle, e` l`atmosfera diffusa e il senso invincibile d`insicurezza dentro cui, volenti o nolenti, si muovono i personaggi. le tecniche di scrittura sono diverse, e non c`e` predominanza dell`una o dell`altra in un dato periodo creativo dell`autore: il quale probabilmente nella scelta si lasciava guidare dal soggetto della novella (dall`introduzione di cesare de marchi).